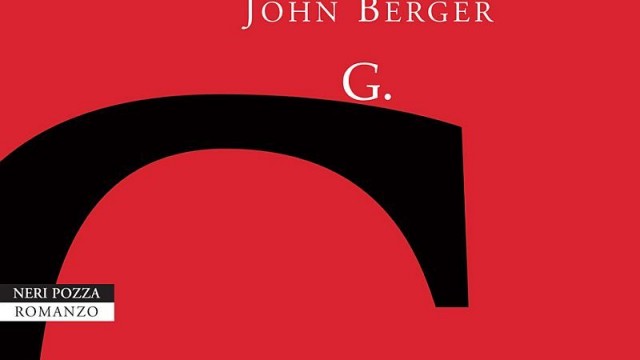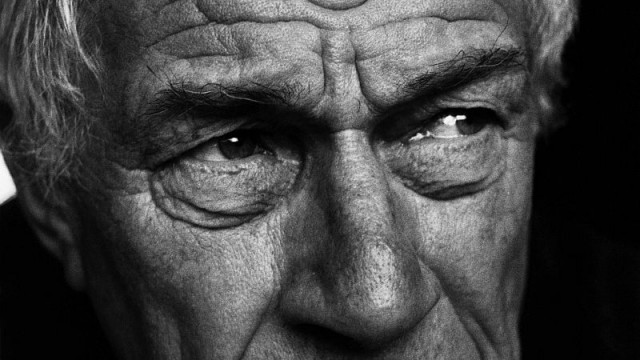ROMA – John Berger è un artigiano del pensiero. Scrive e riscrive una frase, cinque, sei, otto volte. Un combattimento serrato con la scrittura, un corpo a corpo sfibrante, anche dopo sessant’anni di pratica. Trovare le parole giuste è per lui imperativo: anche di fronte a certe domande, si prende la testa fra le mani e sprofonda nel silenzio, immergendosi in se stesso alla ricerca dell’unica risposta possibile. Le frasi risalgono come da un pozzo. “Per parlare del mondo bisogna essere precisi, non c’è posto per l’ambiguità. E l’improvvisazione è rischiosa”.
La fotografia? Troppo rapida
A ottantotto anni, lo scrittore-leggenda, il critico d’arte, poeta, saggista, drammaturgo nonchè vincitore del Booker Prize 1972 (con il romanzo G., recentemente ripubblicato da Neri Pozza) ha appena dato alle stampe l’ultima fatica, Capire una fotografia (Contrasto), raccolta di saggi e testi inediti a cura di Geoff Dyer. “Si impara a leggere una fotografia come si impara a leggere un’impronta, o un cardiogramma. Negli anni ’50, quando ho cominciato a scrivere di queste cose, dicevo che fotografare era un’arte. Gli editori rispondevano che ero fuori di testa, e non mi pubblicavano. Le cose sono cambiate. Per fortuna”. In quegli anni anche Berger si trova a scrutare la realtà manovrando un obiettivo. Impara a stampare i negativi sotto la guida di un maestro d’eccezione, Jean Mohr, con cui continuerà a produrre libri per tutta la vita, cambiando la storia della fotografia. Un giorno, senza preavviso, molla tutto. Vende anche l’apparecchio. “Per me era un mezzo troppo rapido. Dopo ogni scatto, mi giravo a guardare ciò che avevo fotografato, e rimanevo lì ad osservare, coglievo altri aspetti, vedevo altre cose….”. E’ nel “guardare” la chiave per capire l’enigma del più versatile fra gli intellettuali del nostro tempo. Guardare è essere continuamente sorpresi. E’ interrogarsi sulla vita, scovare le intime relazioni che collegano il mondo. “Accompagnare qualcosa di invisibile alla sua incalcolabile destinazione” (da Il Taccuino di Bento, Neri Pozza). Berger osserva la vita e narra ciò che vede, ciò che sente. Ciò che gli viene raccontato. Storie che non sono la sua. In un tempo afflitto da selfie e narcisismo autobiografico, lo scrittore non parla di sé, non lo ha mai fatto. Non è mai stato protagonista della propria narrazione, neppure in G. vicenda esistenziale di un uomo senza padre e senza patria, privo di appartenenze e legami, che in qualche misura pure gli assomiglia. “Non è un romanzo autobiografico, bensì personale. E’ l’ultima storia personale che ho scritto, perché per farla – e ci ho messo otto anni – ho ascoltato principalmente me stesso, invece di ascoltare gli altri”. Scrittura come movimento dall’interno verso l’esterno. Abbandono dell’ ‘io’ per narrare il ‘noi’, l’arte, la società. Per descrivere l’incontro con l’Altro, unico meccanismo capace di produrre l’uomo. E la storia.
Dipingere l’acciaio in fonderia
Nato nel 1926 in un agiato sobborgo londinese, nelle intenzioni della famiglia il piccolo John ha un avvenire da gentleman inglese di successo, “il miglior cavallerizzo della Hortobàgyi”. Il padre – ufficiale di fanteria sul fronte occidentale durante la Grande Guerra – lo mette in collegio a Oxford. Ma a 16 anni, il ragazzo abbandona la scuola: niente liceo, né università, non ci sarà nessun pezzo di carta a certificare le competenze di uno dei più acuti pensatori del Novecento europeo. “Non ero d’accordo con mio padre su cosa è importante nella vita: però, senza che lui me ne parlasse, capivo l’incredibile sofferenza che aveva attraversato durante la guerra. Malgrado le divergenze, ci siamo rispettati”. Dissidente nell’animo, Berger si rifugia nell’arte e inizia una carriera da pittore. Il suo lavoro è inseguire lo sguardo, interrogandosi sul perché delle cose. E’ l’arte a trascinarlo in politica. Trascorre un anno in fonderia, a mettere su tela la fatica degli operai che maneggiano acciaio. “Dietro quei volti, quei corpi ritratti, c’era una precisa visione della società. Come potevo dipingerli senza avere un punto di vista politico?”. Ma è il tempo della minaccia nucleare, il mondo si dondola sull’abisso chiamato conflitto atomico: dipingere non è il mezzo più adeguato all’urgenza della denuncia. “Di fronte alla situazione disperata in cui eravamo, mi pareva che continuare a produrre quadri a olio da appendere in sala da pranzo, fosse lontano anni luce dal tentativo di fare qualcosa”. Berger lascia la pittura (continuerà invece sempre a disegnare), comincia a scrivere. E’ il potere sovversivo della parola ad animarlo. Una parola che capta i legami fra le cose, fra le vite. Non distratta da questioni di stile, o da eleganza verbale, bensì sempre – e per sempre – vigile nei confronti dell’ambiguità dell’esperienza. “La parola è imparziale, l’uso è tutto”.
![o_3f8712fd6d551681_002[1]](http://www.danielacavini.eu/wp-content/uploads/2014/12/o_3f8712fd6d551681_0021.jpg) A lezione dal ‘calzolaio’ George Orwell
A lezione dal ‘calzolaio’ George Orwell
Muove i primi passi al Tribune, settimanale socialista diretto da George Orwell. “Ho imparato molto da lui, era severo con i miei testi, proprio come farebbe un mastro calzolaio con un apprendista. Mi diceva: guarda come hai fatto questo ‘tacco’, non è abbastanza solido. Io lo correggevo, mi ripresentavo, e lui: adesso non è male, però continua a pensarci su, si può fare meglio. Mi ha insegnato la precisione, il rigore”. Un rigore che non abbandonerà più né l’opera né la vita di questo Umanista chino sulle ferite dell’emarginazione, ma mai confinato nei dogmi di una chiesa. Marxista sacrilego. Il passaggio dalla pittura alla scrittura non gli impedisce di continuare ad insegnare disegno, fino al 1955, all’Associazione per l’educazione dei lavoratori. Lo stesso rigore lo porterà – qualche anno dopo, mentre scrive di migranti e comunità rurali abbandonate – a chiudere la vita londinese e a trasferirsi in un cascinale fra i pascoli dell’Alta Savoia, in Francia. E’ qui che vive tutt’ora, nel borgo di Quincy, nemmeno cento abitanti, fra campi e fienili. In mezzo alle montagne Berger coltiva orti, munge le mucche. Con i contadini siede e impara, perché “sono loro la mia unica università”. E fa il vuoto interiore. Per dare vita alla voce plurale delle cose, alle migliaia di storie che gli vengono incontro. L’opera bergeriana conta oggi decine di titoli d’arte, letteratura, saggistica, fotografia. Ma anche poesia, “consolazione condivisa”, infiltrata ovunque. E politica sparsa su tutto, perché tutto di politica è fatto. “In potenza, la lingua è la nostra sola casa, l’unico luogo abitabile che non può esserci ostile”.
Una zuppa per ogni storia, come Esopo
Se c’è una cosa che Berger detesta – oltre alle interviste – è essere chiamato romanziere. “Piuttosto sono un narratore, uno storyteller nel senso tradizionale del termine. Colui che se ne va in giro per il mondo e la sera offre una storia in cambio di un letto e di un piatto di zuppa. Sono come Esopo: un traghettatore di storie”. Berger porta alla luce le storie come apparizioni, le spinge attraverso il tempo e lo spazio verso di noi. Per riempire un “silenzio intollerabile”. Recentemente, la traduttrice e amica di una vita Maria Nadotti ha riunito un frammento di 60 anni di scritti nell’antologia, Contro i nuovi tiranni, (Neri Pozza), affresco di resistenza al carcere planetario in cui il neoliberismo finanziario ci sta schiacciando. Il Berger –Esopo, si oppone alla tirannide del “profitto liquido”, del consumismo che consuma ogni dubbio, dei muri costruiti non per rinchiudere qualcuno, ma per escludere tutti (gli Altri). L’aedo-contadino si oppone alla narrazione mediatica dell’imperativo del Libero Mercato e delle sue speculazioni, e lo fa nel modo pacato di sempre. Non accusa, evoca immagini. Non getta, ripara (“una sola cosa riparata ne cambia altre mille”). Non discrimina, tesse. Invitandoci a ripensare le frontiere della politica, il taccuino del traghettatore di storie ci ricorda che quando la disumanità – come la morte – dissolve il nostro peso di uomini, l’opera di riparazione resta affidata alle parole dei poeti. “Non so dirti cosa fa l’Arte e come lo faccia – scrive Berger – ma so che spesso ha giudicato i giudici, chiesto vendetta per gli innocenti e mostrato al futuro quel che il passato ha sofferto, così che non lo si è più dimenticato. So anche che quando l’arte fa questo, i potenti ne hanno paura. E che a volte una simile arte circola fra la gente come una leggenda, perché dà senso a quello che le brutalità della vita non sanno spiegare, un senso che ci unisce, perché è finalmente inseparabile dalla giustizia. L’arte, quando funziona così, diventa il punto d’incontro dell’invisibile, dell’irriducibile, del duraturo, del coraggio e dell’onore”.
Daniela Cavini